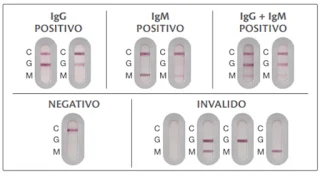Monday, October 17, 2022
Test
Da molte settimane è perlopiù un vociferare ufficioso, ma ora pare essere diventato un fenomeno riconosciuto, prima a livello mediatico e poi scientifico: tra la comparsa dei sintomi di Covid-19 e l'ottenimento di tamponi con esito positivo si tra creando in molti casi uno scarto temporale sempre maggiore, un ritardo che rischia di incrinare ulteriormente il già fragile sistema di contenimento dei contagi.
In questo caso non si tratta (più) di un ritardo di natura burocratico-organizzativa come era nelle prime fasi della pandemia, poiché tra test in farmacia e analoghi domestici la possibilità di eseguire un tampone è per chiunque sostanzialmente immediata. Il ritardo, invece, dipende ora da questioni prettamente biologiche, nel senso che molte persone manifestano sintomi compatibili con il Covid-19 risultando però ancora negative, arrivando a positivizzarsi solamente quando ormai i sintomi si sono affievoliti o addirittura sono del tutto scomparsi.
PUBBLICITÀ
Una situazione, questa, che crea più di una complicazione a livello organizzativo. Anzitutto, il singolo paziente non è in grado di stabilire, durante la fase acuta dei propri sintomi, se sia stato infettato da qualche variante del Sars-Cov-2 o se invece si tratti di un patogeno e di una malattia diversa. Secondo, l'arrivo di un tampone positivo quando ormai la malattia e in via di guarigione crea qualche stortura burocratica, nel senso che porta a iniziare il periodo di isolamento quando ormai potrebbe volgere al termine, favorendo indirettamente la trasmissione virali nelle giornate iniziali della malattia, quando si è già sintomatici.
Le origini incerte del ritardo
Se sul fatto che questo ritardo sia reale - e non solo una suggestione - ci sono ormai pochi dubbi, allo stesso tempo su che cosa lo determini restano parecchie incertezze, tanto che al momento tutto ciò di cui disponiamo sono delle ragionevoli ipotesi.
La prima delle teorie più gettonate riguarda la diversa dinamica con cui le più recenti varianti di Sars-Cov-2 circolano nell'organismo: se infatti le alte vie aeree e il naso fossero le ultime parti dell'apparato respiratorio a essere interessate dal virus, questo potrebbe giustificare la presenza di sintomi vistosi anche quando il tampone non risulta ancora positivo. Su questa direzione punterebbe anche l'evidenza che l'accumulo di virus nel naso con la variante omicron è mediamente inferiore rispetto alla variante delta. L'altra ipotesi che ha ottenuto un buon consenso è che, soprattutto per chi ha già avuto il Covid-19 o ha completato il ciclo vaccinale e ha quindi gli anticorpi in circolo, il sistema immunitario sia diventato più reattivo e porti alla comparsa di sintomi di risposta molto precocemente, anticipando la diffusione virale nell'organismo e quindi la positività del tampone. Contro questa ipotesi, tuttavia, c'è l'evidenza che anche persone che - almeno formalmente - incontrano per la prima volta il nuovo coronavirus e i suoi antigeni manifestano comunque il ritardo nella positività dei tamponi (potrebbe però trattarsi di persone - non vaccinate - che in passato hanno contratto la malattia in forma asintomatica e non se ne sono mai accorte). La mancanza di studi scientifici sistematici non permette ancora di fare chiarezza su questo punto.
Una terza possibilità, forse aggiuntiva più che alternativa alle altre due, è che il ritardo sia il riflesso di come è cambiato nel tempo il modo in cui il tampone nasale viene eseguito. Nel fai-da-te, infatti, si ritiene che molte persone non raccolgano con particolare cura né in grande profondità il materiale biologico che impregna il tampone, determinando una frequenza più alta dei falsi negativi, a maggiore ragione in un momento come quello iniziale della malattia in cui la carica virale nel naso è più bassa. Infine, una ulteriore considerazione riguarda il cambiamento di tutta la dinamica di circolazione del virus da quando la variante omicron è diventata prevalente: è diminuito il tempo di incubazione, è diminuita la durata media di manifestazione dei sintomi, ed è cambiato quindi più in generale il modo in cui il nuovo coronavirus interagisce con l'essere umano. In qualche modo, questo potrebbe avere avuto un riflesso anche sul tempismo dei tamponi.
Più che le cause, le conseguenze
Anche se molto del dibattito in seno alla comunità scientifica e a livello pubblico si concentra sul perché di questo ritardo, probabilmente a meritare attenzione è soprattutto la questione delle conseguenze che determinerà, in particolare dopo l'estate. Come sappiamo, infatti, già ora le restrizioni e i tracciamenti sono notevolmente ridotti rispetto al passato, a cui si aggiunge il fatto che ci sono persone che non si sottopongono al tampone anche da sintomatiche per timore di risultare positive, altre che svolgono il test in casa senza registrarlo né ripeterlo nelle strutture preposte, altre ancora che - magari sintomatiche - vedendo un primo tampone negativo non si preoccupano di ripeterlo nei giorni successivi. Tutto ciò ha come effetto che la nostra capacità di fotografare la reale circolazione del virus e di impedire il contagio da persona persona è drasticamente diminuita, a maggiore ragione se il tampone positivo che dovrebbe sancire l'inizio del periodo di isolamento arriva quando ormai la gran parte del danno in termini di contagio rischia di essere già stata fatta.
Questa situazione di attuale disordine e scarso rigore, inoltre, è allo stesso tempo anche causa dell'impossibilità di definire contorni precisi per il ritardo diagnostico stesso, sia in termini di numero di giornate medie sia come incidenza e come prevalenza delle diverse varianti. Il che a sua volta impedisce di pianificare strategie alternative o diffondere consigli su come riconoscere in maniera alternativa Covid-19, visto anche che i sintomi si stanno facendo sempre meno specifici e sono confondibili con quelli di altre infezioni virali a carattere respiratorio, se non addirittura con allergie o fastidi da aria condizionata.
La domanda che verrebbe da porsi a questo punto, dunque, è se lo strumento del tampone così come inteso in questo momento sia davvero ancora efficace come attrezzo di diagnosi dell'infezione da Covid-19 e come strategia per limitare la circolazione del virus. Anche se al momento non ci sono particolari preoccupazioni poiché la pressione sulle strutture sanitarie è molto bassa, il problema potrebbe porsi in maniera importante qualora con la stagione fredda si arrivasse a un aumento importante dei casi che richiedono trattamenti ospedalieri. E come abbiamo imparato dalle scorse due estati, abbassare la guardia adesso e disinteressarsi al problema sarebbe una grave mancanza che rischieremmo di pagare con un conto salato.
Saturday, October 15, 2022
ORO ITALIANO
Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi ha presentato una proposta di legge che (1) prevede che l’oro che si trova nei forzieri della Banca d’Italia sia di proprietà dello Stato e la Banca d’Italia ne sia la sola depositaria. Questa richiesta fatta dal parlamentare della Lega ha lo scopo di dare una interpretazione autentica ad una norma che, evidentemente, non prevede lo Stato come proprietario dell’oro della Banca d’Italia. Avendo l’oro la stessa provenienza e natura di eventuali riserve in altre valute pregiate (dollaro statunitense) di cui non si contesta la proprietà, non si capisce perché mai la “nazionalizzazione” si limiti all’oro.
Le motivazioni esposte nella relazione illustrativa affermano che “il tema della proprietà delle riserve auree nazionali, sebbene inconfutabile nei cuori di ogni cittadino italiano, è carsicamente apparso nella discussione parlamentare come tema di dibattito”. Esiste, secondo Borghi, “un vulnus normativo, se non addirittura una vera e propria errata interpretazione” per cui con interpretazione autentica occorre “riportare l’esegesi della normativa nazionale in una situazione di certezza e di chiarezza.” Con una interpretazione normativa si cambia la proprietà di tutto l’oro che, secondo palazzo Koch, è inequivocabilmente suo: “Il quantitativo di oro di cui la Banca d’Italia è ad oggi proprietaria è frutto di una serie di eventi che hanno permesso all’Istituto i diventare, nel tempo, uno dei maggiori detentori al mondo di metallo prezioso” (2).
Non è difficile inquadrare questo disegno di legge nella filosofia generale di Claudio Borghi che ruota tutta attorno al concetto di sovranità nazionale e, quindi, all’uscita dall’euro, più volte auspicata anche se recentemente smentita o riqualificata quale preferenza personale, non presente nel contratto di governo, per ora.
Ma la proposta di legge di Borghi non nasce come una esigenza disgiunta da problemi politici in atto, anzi essa va chiaramente connessa con la richiesta di un politico tedesco che, a memoria, proponeva che una legge europea sancisse che i saldi del target 2 fossero garantite dall’oro delle banche centrali dei singoli paesi debitori. Ora è noto che, per quel che riguarda il target 2, la Germania abbia un saldo positivo di 900 miliardi di €, mentre l’Italia abbia un debito di 400 miliardi di €.
Faccio riferimento al mio articolo apparso su questa rivista per ricordare che i saldi target 2, finché i paesi aderenti rimangono aderenti all’Unione Europea, sono come i saldi a debito o a credito che filiali diverse di una stessa banca hanno tra di loro. Il problema nasce, evidentemente, quando un paese intende uscire dall’Unione Europea, e sia chiaro che a voler uscire non è necessariamente il paese debitore, ma può essere tranquillamente anche il paese creditore. In questa evenienza, e ciò è stato chiarito dal presidente Draghi, i saldi autocompensati fino al momento in cui le banche centrali dei singoli paesi sono solo filiali di una stessa banca, nel momento della eventuale rottura devono essere pagati dalle banche centrali dei paesi debitori alle banche centrali dei paesi creditori.
Appare allora evidente che in questa improbabile, ma non impossibile, evenienza le banche creditrici cerchino di precostituirsi quegli strumenti giuridici che permettano loro di realizzare il loro credito e che esso non divenga un NPL (not performing loan); avere come garanzia l’oro detenuto presso le banche centrali pare essere una garanzia gradita al parlamentare tedesco.
E’ tuttavia interessante chiedersi quanto sia l’oro detenuto o depositato presso la Banca d’Italia; ebbene, le riserve ammontano a 2.452 tonnellate (95.493 lingotti), pari ad un valore corrente di 85.3 miliardi di euro, il valore degli interessi passivi che paghiamo ogni anno, importo ben lontano dal saldo target 2.
Ne deriva che in caso di uscita dall’euro, alla Banca d’Italia per rimborsare il saldo passivo, dovrebbe vendere i titoli di stato in suo possesso (il 16% del debito totale ovvero 370 miliardi circa) il che naturalmente causerebbe il crollo nella quotazione dei titoli stessi e quindi il default immediato di tutto il sistema bancario nazionale.
Il testo del disegno di legge così recita: ”Il secondo comma dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148, si interpreta nel senso che la Banca d’Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all’estero”.
“L’oro è della Banca d’Italia. Non è dello Stato (e quindi dei cittadini) e tantomeno dei partecipanti privati al capitale, che sulle riserve non possono vantare alcun diritto (cosa che, unico elemento positivo, è stata specificata anche nel discusso decreto IMU – Bankitalia).
Ci è stato specificato che è impossibile per la stessa Banca disporre liberamente della Riserva dato che la stessa costituisce un presidio fondamentale di garanzia per la fiducia nel sistema Paese. Considerando però che la Banca Nazionale fa parte dell’Eurosistema, anche le riserve ne fanno parte e contemporaneamente garantiscono insieme a quelle degli altri Paesi europei il sistema stesso. “ Intervista a Salvatore Rossi DG Banca d’Italia.
UN PIANO PER FREGARE I NAZISTI. Era un funzionario serio e scrupoloso, il capo si poteva fidare. Gli chiese dunque di condividere un disegno: in vista dell’arrivo dei nazisti, che nel frattempo avevano occupato la città, occorreva nascondere l’oro per evitare che venisse requisito. Il piano che il capo propose al funzionario era semplice: fingere che l’oro fosse stato trasferito mesi prima altrove, a Potenza, città che si presumeva presto nelle mani degli angloamericani. Occorreva creare la documentazione falsa che dimostrasse l’avvenuto trasferimento dell’oro e bisognava nascondere l’oro, che sarebbe rimasto lì, nelle intercapedini dei sotterranei, in quelle che in Banca d’Italia chiamano le sacristie. Si parla di un funzionario della Banca d’Italia che qualche giorno dopo l’8 settembre 1943 venne chiamato dal suo capo. Era un funzionario serio e scrupoloso, il capo si poteva fidare. Gli chiese dunque di condividere un disegno: in vista dell’arrivo dei nazisti, che nel frattempo avevano occupato la città, occorreva nascondere l’oro per evitare che venisse requisito. Il piano che il capo propose al funzionario era semplice: fingere che l’oro fosse stato trasferito mesi prima altrove, a Potenza, città che si presumeva presto nelle mani degli angloamericani. Occorreva creare la documentazione falsa che dimostrasse l’avvenuto trasferimento dell’oro e bisognava nascondere l’oro, che sarebbe rimasto lì, nelle intercapedini dei sotterranei, in quelle che in Banca d’Italia chiamano le sacristie. Il funzionario - accettò e iniziò a lavorare per organizzare l’inganno. Il 20 settembre era tutto fatto: i lingotti spostati, murata una apertura, creati i documenti falsi per certificare un trasferimento mai avvenuto. Ma il governatore della Banca d’Italia ci ripensò e ordinò di rimettere l’oro a posto. Due giorni dopo i tedeschi entrarono e presero l’oro. Lo spedirono prima a Milano, poi in Alto Adige, poi in una miniera abbandonata in Germania. E segnarono quei lingotti con la svastica. Una parte di quell’oro sarebbe tornato in possesso dell’Italia oltre 50 anni dopo. Intervista di Salvatore Rossi DG di Banca d’Italia.
La Giustizia Populista
Non sono solo gli avvocati penalisti (e molti magistrati) a bocciare la riforma della prescrizione proposta dal governo. Scende in campo anche l’Associazione italiana dei professori di Diritto penale (Aipdp), che in una nota di ieri ha espresso “forte preoccupazione per la gestione della ‘questione penale’ nel suo complesso, nell’attuale situazione politica”. Già dieci giorni fa, durante le audizioni convocate in fretta e furia dalla commissione Giustizia della Camera, tutti i rappresentanti dell’accademia italiana avevano sottolineato gli effetti nefasti che l’abolizione – di fatto – della prescrizione dopo il primo grado di giudizio avrebbe sul sistema giudiziario. Una proposta che dall’Aipdp viene definita “pura propaganda”, perché priva di “qualsiasi rapporto con i problemi di oggi” e perché rischia “di avere un impatto distorsivo, se non devastante sul sistema”. Ma a finire nel mirino dei professori è l’intero insieme di politiche del governo in materia di giustizia, segnato dal trionfo del “populismo penale”, fatto di “messaggi volti a coagulare consensi, a soddisfare un ‘sentimento di giustizia’ repressiva e vendicativa, e paure non sempre fondate su dati di realtà, spesso alimentate anche da una propaganda mirata”. Siamo, dunque, al “governo della paura”, basato su “un uso propagandistico (supportato dai mass media) del diritto punitivo, che minaccia di punire o di punire sempre di più, come se la minaccia di maggior pena di per sé significasse un rafforzamento della tutela”. Ne risultano riforme che aprono le porte a una “giustizia infinita, e ad impatto carcerario massimo”. “In questo avvio di legislatura – scrivono i professori di diritto penale – il segno dominante, tipico del populismo penale, sono leggi usate come messaggi volti a coagulare consensi, a soddisfare un sentimento di giustizia repressiva e vendicativa, e paure non sempre fondate su dati di realtà. E’ dunque con profondo senso di preoccupazione che esprimiamo il disagio per la riduzione dei problemi del penale a temi di propaganda, e per prospettate torsioni tanto punitive sulla carta, quanto controproducenti per una ragionevole costruzione e difesa di una legalità rispettosa dei diritti di tutti”. Ben detto.
Friday, October 14, 2022
Pubblico
cosa vuol dire pubblico ludibrio
Pubblico ludibrio: cos’è questa pratica ormai sconosciuta
I libri di storia raccontano come fosse diffusa la pratica del pubblico ludibrio, un modo di fare delle società antiche di cui oggi si è persa traccia e forse anche il ricordo. Di cosa si tratta? A cosa serviva? E perché non si pratica più?
Che cos’è il pubblico ludibrio
Entrando nel merito per pubblico ludibrio sono da intendersi tutte quelle pratiche che venivano messe in atto dalle autorità civili per punire colui che si era macchiato di qualche colpa con lo scopo ulteriore di “educare” il resto della popolazione. Costringere una persona a camminare per le vie principali della città con delle pietre appese al collo o di portare la gogna, significava sottoporla ad un’umiliazione tale che, oltre ad avere la funzione di remissione della colpa commessa, indicava la sorte di tutti coloro che avrebbero voluto commettere altri reati.
I diritti del condannato
Questi metodi erano diffusissimi in un’epoca in cui i sistemi giudiziari e penitenziari erano ancora in divenire e poco sviluppati. Durante il pubblico ludibrio alle persone soggette a questa pena venivano sospesi a tempo tutti i diritti e le tutele che gli spettavano; per questo motivo durante la gogna o le altre pratiche le altre persone potevano lanciargli contro pietre e altri oggetti (non ultime anche feci e deiezioni fresche). Nei casi più estremi, dove la colpa era considerata più grave o il condannato non godeva di favori, questi poteva anche essere lapidato e rimanere ucciso dai colpi delle pietre. Nessuna condanna in quel caso per l’omicida in quanto, come detto, i diritti dei condannati erano sospesi.
Le ragioni di tale pratica
Come abbiamo detto le ragioni del pubblico ludibrio erano, possiamo dire, di ordine sociale, per una sorta di mantenimento dell’ordine pubblico. Nonostante il più delle volte terminassero in manifestazioni caotiche, dove tutti si sentivano autorizzati a compiere le peggiori azioni nei confronti del condannato, tale pratica era propedeutica a scoraggiare altri a compiere quelle che erano considerate le colpe maggiori. Una sorta di applicazione del detto “colpirne uno per educarne cento”.
Una particolarità della pratica del pubblico ludibrio è da registrare nell’origine etimologica del termine ludibrio. Questa parola, infatti, viene dal latino ludibrium che significa schernire. L’obiettivo infatti era proprio quello di schernire e ridicolizzare chi si era macchiato di un reato.
Un capovolgimento esagerato?
Oggi la situazione è notevolmente cambiata e nei casi in cui la comunità insorge contro qualcuno che ha commesso una colpa considerata gravissima (solitamente nei casi di molestie nei confronti dei bambini) intervengono le forze dell’ordine per salvaguardare la vita del colpevole. C’è chi lamenta la condizione attuale dove si registra una certa sfacciataggine di chi viene colto in flagrante, quasi come godesse di una sorta di impunità, con un sistema giudiziario lento o farraginoso per cui spesso la percezione del “chi sbaglia paga” non è più così netta, provando nostalgia per pratiche come quella del pubblico ludibrio. In realtà questi tipi di deterrenti funzionavano fino ad un certo punto ed è importante avere la lucidità di giudizio nei fenomeni analizzandoli per quello che sono, per la loro reale applicazione e per quali sono le cause che ne limitano la portata e soprattutto l’efficacia.
Subscribe to:
Comments (Atom)